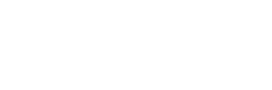Dodici anni fa, nel 2010, scrivevo sul blog di star vedendo ogni giorno più persone unirsi alla comunità di Internet; notavo in particolare che una gran parte di esse non apparteneva più alla famiglia degli specialisti del computer o dei nerd, si trattava invece di persone che usano un computer così come mia madre usava allora il telefono o il televisore. Oggi come dodici anni fa definirò l’Information Technology – la tecnologia dell’informazione – come la capacità di mettere insieme le cose, applicare un’idea (aggiungendoci anche un po’ di intelligenza) e rendere il sistema risultante in grado di fornirti un’informazione. Di qualsiasi tipo. Le cose dell’IT possono avere un componente materiale, come la tastiera di un computer e tutto ciò che c’è al suo interno; le cose possono essere semplicemente idee, immateriali, come le istruzioni date a un computer o a un insieme di computer attraverso la programmazione. La tecnologia le elabora per te, e alla fine di questo processo ci sono delle informazioni. Queste informazioni possono essere semplici risposte a domande che potresti avere, domande come: “Qual è la linea di autobus che porta alla stazione?”, o calcoli complessi come la mappa del genoma umano o i milioni di anni di vita di una stella. Queste informazioni possono anche essere un’altra informazione che può essere utilizzata per un nuovo calcolo, in una sequenza di azioni: pensa a una nave, che ha una rotta verso la sua destinazione, una rotta che deve essere seguita punto dopo punto per raggiungere il porto di destinazione. Bene, questa definizione di Information Technology è schietta, precisa. Ma volevo mantenerla semplice, guardandola nello stesso modo in cui la guardo tutti i giorni. Come ho scritto, alcune persone amano la tecnologia anche se è fine a sé stessa. Io no. Mi piace mettere insieme le cose, mi piacciono i risultati e mi piace molto l’output, molto più della tecnologia che sta dietro, anche per questo la fotografia digitale per me è un mezzo e non il fine.
La scienza missilistica – da Von Braun, Laika, Gagarin, ai radiotelescopi, a tutti gli scrittori dal 1950 al 1975, da “Star Trek” alla “Fondazione” e da “2001: A Space Odissey” (1968), all’atterraggio lunare di Apollo (1969) e allo Shuttle (“Guerre Stellari” è invece un bel Fantasy) hanno avuto un grande impatto sulla mia generazione. Stavamo sognando di andare sulle stelle, di far parte di un viaggio verso lo spazio, di poter incontrare esseri di un altro pianeta. No, non dico “Boldly go”: era qualcosa di diverso. Da ragazzo, durante i miei primi anni di scuola, ero assolutamente sicuro che un giorno l’uomo avrebbe incontrato civiltà millenarie, sconosciute e non terrene. Nella mia mente tutto questo non era finzione o speranza: ne ero semplicemente sicuro. Guardavo questa serie televisiva, “Spazio: 1999” (avevo la tivù a valvole, in quegli anni, solo immagini in bianco e nero col primo e secondo canale, Silvio Berlusconi stava muovendo i primi passi nella pubblicità italiana e Goldrake non c’era ancora). In “Spazio: 1999” c’era questo scienziato, Victor Bergman: il mio personaggio preferito. Victor Bergman lavorava in squadra con David Kano. David era lo specialista di computer della Base Alpha, una base sulla luna, naturalmente (retaggio di una serie di poco precedente, UFO, nella quale spiccava Gabrielle Drake primo sogno erotico di allora ed è bella ancora oggi, a quasi ottant’anni). Alpha Moon Base aveva questo computer grande e nero (qualcuno sta pensando all’IBM?), con la voce metallica (i calcolatori di un tempo avevano tutti la voce metallica, non come Alexa) che usciva dagli altoparlanti vicino ai monitor di servizio; Victor e David solevano porre domande complesse al computer e il computer, a parte un caso solo e proprio all’inizio della storia, aveva sempre una risposta, meravigliosamente scritta su un piccolo pezzo di carta termica (una specie di scontrino del supermercato) che David leggeva al pubblico di spettatori (ricordo che era solito trovare molte cose, sul quel pezzo di carta: lunghe discussioni e lunghe spiegazioni). Il computer della Base Alfa aveva una risposta per Victor, per David e per i trecento abbandonati nello spazio. Non erano soli: il computer era lì per aiutarli. Quindi, con l’entusiasmo del ragazzo, avevo immaginato che se fossi stato capace di programmare un computer e fare in modo che fosse come quello della Base Alfa avrei potuto aiutare gli altri ma prima di tutto aiutare me stesso. A mettere insieme le cose. Per avere risposte alle domande, e ne avevo tante, almeno tante quanto la fantasia. Quindi il mio primo desiderio, nel 1975, era stato quello di diventare un programmatore di computer: e soprattutto di avere un computer. Arrivò prima la macchina fotografica, la Kodak regalo di compleanno, quella del primo scatto; il VIC20 lo presi un po’ dopo, con i soldini di una borsa di studio della Cassa di Risparmio (mamma non voleva, ma il prof delle medie disse: “signora per carità, lo faccia giocare con il computer, domani sarà una professione”).
Le cose passarono: essere un programmatore di computer non era il solo desiderio di ragazzino che avevo. Per un periodo sognai fare il pilota (ma non potevo entrare in accademia: portavo già gli occhiali, e per trasferirsi e frequentare un tecnico fuori città ci volevano più soldini che per il VIC). Poi iniziai a scrivere: sono stato apprezzato come scrittore in erba a scuola, e volevo fare la carriera di giornalista. Ma anche in questo caso sapevo di non avere i soldi per l’università: mio padre non c’era e mia madre era senza un lavoro stabile, altro sostegno di famiglia che non fosse minimo non c’era – altri tempi altre scelte e cose che non sapevo o che comunque non dipendevano da me. La decisione quindi era stata quella di continuare gli studi in una scuola professionale e cercare un lavoro, da iniziare già a quindici anni, come altri amici. Capitò di discutere i programmi di studio del Volta, l’istituto tecnico di Trieste: era considerata, allora, una delle scuole migliori e fra le più severe. Insegnanti solitamente molto di destra (all’epoca non è che la differenza mi fosse chiara) e molto esigenti, tante ore da passare in classe e altrettante da passare a studiare a casa. La mia più cara insegnante, Maria Vigori, conosceva la mia situazione familiare, mi spingeva verso il Volta poiché offriva ottime opportunità d’impiego. Lì non conoscevo però nessuno, tutti i miei amici avevano deciso per scuole diverse: ero spaesato e preoccupato dalla prospettiva di dover andare da solo. Poi mia madre disse: “Lascia stare. Non puoi farcela, è troppo difficile per te”. Un paio di giorni dopo avevo deciso ed ero iscritto.
Nel 1983 ho comprato il mio primo computer. Gli anni Ottanta erano l’età dei primi calcolatori domestici; il mio primo era un Commodore VIC20, il VIC. Bello, ma ho capito subito che non era abbastanza per me: volevo più colori e più capacità, e soprattutto oltre ai programmi mi piacevano, naturalmente, i giochi. Avevo la sensazione che per me “studio” significasse “computer”, e nel 1984, con una seconda borsa di studio, ho comprato il mio Commodore 64. Era un caro amico, un compagno che è rimasto per tanti anni, durante tutta la mia carriera scolastica. Ho continuato a usarlo, sviluppare, attaccarci cose nuove, sperimentare software. E a scuola c’era un insegnante di tecnologia, Alessandro Predonzan: è rimasto con la nostra classe solo per un anno, ma ha introdotto i computer nel suo corso e ha spiegato come usare il BASIC e le tecniche più avanzate (lavorammo, per un paio di lezioni, sul Digital della scuola: Digital Compaq sarebbe tornata da me dopo i vent’anni). Ho ancora in un cassetto il libretto, la copertina strappata e poche pagine sul BASIC, che Predonzan ci aveva regalato; mi è caro. Grazie a quel corso, però, ho capito che non sarei stato mai un buon programmatore: altri erano più intelligenti (ricordo soprattutto Gabriele Cutazzo e Alessandro Gamboz), e fondamentalmente non ero molto incline a impegnarmi in matematica. Ma il mio Commodore, a casa, era il più sviluppato: aveva persino il modem (e chi ce l’aveva, negli anni Ottanta e fra i ragazzi, un modem SIP). Mentre altri erano in grado di scrivere meglio, molto meglio di me, un programma, io ero capace di mettere insieme le cose per avere in mano alla fine qualcosa di più veloce e con più potenza di calcolo. E soprattutto, il mio Commodore era collegato a una rete. Ho iniziato a capire quale fosse la mia strada.
I got you to hold my hand; I got you to understand. I got you to walk with me; I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight; I got you to hold me tight. I got you, I won’t let go. I got you to love me so. I got you babe.